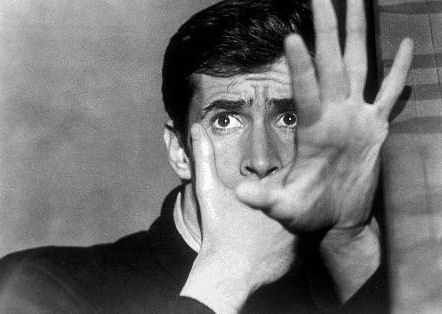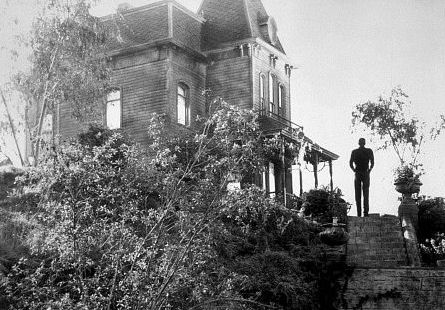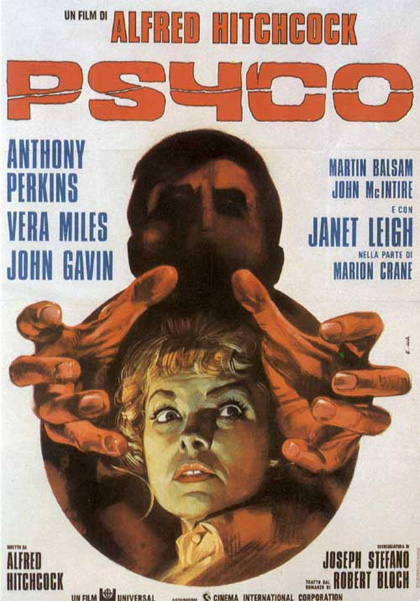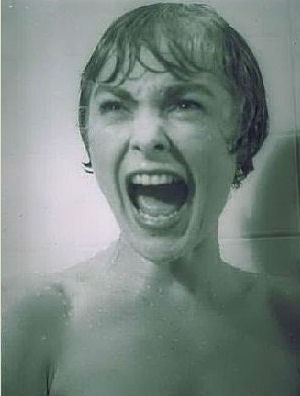|
Psyco
comincia con una panoramica tra le più banali della città di Phoenix
in Arizona; poi la camera inquadra due amanti. Non si possono
sposare perché lui è pieno di debiti. La ragazza torna in ufficio.
Una didascalia ci dice che siamo in un certo mese, e il giorno è
venerdì. Il che significa che le banche saranno riaperte soltanto il
lunedì successivo. Colta da una sorta di «raptus», la donna
innamorata si impadronisce di ventiquattro milioni, riscossi dal suo
principale per una villa (la giovane ha avuto l’incarico di portarli
in banca..) e fila verso l’amante. Che nessuno conosce a Phoenix e
che è commesso in una lontana bottega di un paesotto fuorimano.
Essa, che ha il nome piuttosto comune di Marion, confida dunque
nell’impunità; quando si accorgeranno del furto, il lunedì
successivo, sarà nascosta in campagna, felice, sposata e lontana da
ogni ricerca della polizia.
Una vicenda come tante, un po’ malinconica, tanto è vero che subito
lo spettatore simpatizza con la fuggitiva. Che, badate bene, ha
rubato a un tipo detestabile (il cappellone dell’anziano compratore
è più che sufficiente a suggerire una certa bestialità
esistenziale...) e ha rubato non per sé, ma per amore, per sposare
l’essere amato e regolarizzare la sua posizione. Ma ecco che un
poliziotto, insospettito dal fatto che Marion s’è addormentata in
macchina, la interroga. L’uomo ha gli occhiali neri e non è, secondo
la caratteristica ideologica del regista, che un’immagine fatale, la
presenza della Grazia nella vicenda privata del protagonista. È Dio
che le fa un piccolo segno dicendo: «Marion, hai sbagliato, ma fai
ancora in tempo a pentirti e a riparare. Volta la macchina e torna
indietro».
Marion da principio non obbedisce, anzi cambia l’auto rimettendoci
settecento dollari; poi sbaglia strada e chiede ricovero, sotto la
pioggia scrosciante, a un motel senza clienti. Qui incontra Norman,
il padrone del motel; un ragazzo simpatico, solitario, gentile.
Sotto l’aspetto innocente, Norman nasconde una gravissima malattia:
è uno psicopatico, la cui personalità è andata da tempo in frantumi.
Norman uccide Marion, che ha ormai conquistato la salvezza
dell’anima, e ha deciso di restituire il denaro. L’episodio della
conversione della protagonista appare come una delle pagine più alte
del film: l’orrore si sposa alla tenerezza, l’ineffabile prende
nella nostra anima il luogo lasciato libero dal delitto.
Raccomandiamo alle «anime belle», scandalizzate dalle pugnalate di
Rocco e i suoi fratelli, le coltellate che troncano,
sotto la doccia, la giovane vita di Marion. Saremmo lieti,
malignamente lieti, di conoscere la loro opinione. Verità al di là
dell’Oceano, falsità di qua, come suggeriva Montaigne? Psyco,
ecco perché non è un film banale, un’opera grandguignolesca, propone
dunque con sincerità e coerenza una problematica della salvezza
attraverso i meandri bui e incerti dell’esistenza più comune. Il
personaggio centrale del film non è certamente Anthony Perkins (la
cui interpretazione dello psicopatico è addirittura incantevole...)
ma Marion, personaggio sano e normale. Hitchcock, inglese ed educato
dai gemiti, dà sempre nelle sue pellicole un giudizio sulla vita
americana, e insomma sulla finale moralità del successo e del
denaro. Marion è un personaggio che commuove perché la sua verità è
quella dell’amore. Lo psicopatico è «l’altro da sé», la cui
alienazione Hitchcock, forse un po’ frettolosamente, secondo uno
schema psicanalitico da rivista dozzinale, attribuisce al trauma per
il tradimento della madre che, vedova, s’è accoppiata con un uomo
sposato..., un personaggio dunque che è già di un altro mondo, di
una diversa realtà anche se, disgraziatamente, è ancora in grado di
fare il male.
Un altro tipo su cui si appunta l’attenzione del regista è il
fidanzatoamante di Marion, un uomo leale, non fortunato che,
inevitabilmente, si affeziona subito alla sorella della scomparsa.
Ma non si tratta di un personaggio tipicamente hitchcockiano, che
sarà riconoscibilissimo invece nell’agente privato incaricato di
ricuperare i ventiquattro milioni inspiegabilmente scomparsi. Anche
qui, quasi distrattamente, fa capolino il giudizio su un certo
comportamento della società USA. Si tratta, abbiamo detto, di un
agente privato. Al principale di Marion non interessava affatto il
fallo della ragazza, ma il ricupero dei quattrini. Come a suggerire
che in una civiltà prona alla morale del successo ciò che conta non
è il mezzo ma il fine. Se Marion ce la fa, se riesce a nascondersi
in un posticino fuori mano, essa è una «dritta» cui bisogna fare
tanto di cappello. Tanto, si sa, i soldi piacciono a tutti.
Marion è diversa. Intanto bisogna stare attenti alla sua
caratterizzazione fisica. Il regista, questa volta, non ha scelto
una bellezza aristocratica, conie faceva ai tempi di Grace Kelly, o
una splendida creatura come ha fatto di recente con Kim Novak,
protagonista de La donna che visse due volte. Ha scelto Janet
Leigh, una donna non più giovanissima (è la moglie di Tony Curtis),
celebre alcuni anni fa, ma ora sul declino. Probabilmente Hitchcock
ha ricordato l’ultimo film di Orson Welles, L’infernale Quinlan,
in cui c’era una sposina che faceva una pessima esperienza. La
sposina era raffigurata da Janet Leigh. Perché dunque questa scelta?
Perché tanto Grace Kelly che Kim Novak sono bellezze eccezionali,
mentre Janet Leigh (che, ricordiamolo, ha in Psyco la parte
di un’impiegatina), dev’essere una donna attraente ma non troppo.
Magra, elegante, un po’ sciupata, Marion è proprio la ragazza che,
stanca d’attendere, s’è concessa a un amore illecito; ma che, nello
stesso tempo, è ansiosa di normalità, di nozze regolari e di
complimenti per la buona scelta da parte del parentado.
Ci sono due momenti illuminanti nel film, a questo proposito. Uno
riguarda la scelta dei luoghi e l’altro un breve momento nella prima
parte della vicenda. Hitchcock ha capito che il modo migliore di
conferire risalto alla tragedia di Marion era quello di sottolineare
la mediocrità, e quasi
l’umiltà, delle sue ambizioni. L’ambiente meschino, comune della
città da cui fugge trova un contrapposto nella banalità del paesotto
in cui essa cerca un rifugio e nel quale non arriverà mai. L’amante
è infatti commesso in un negozio di ferramenta, un tipo che sta a
metà tra il cittadino e l’uomo di campagna. Marion dunque portando i
milioni all’innamorato, che ne ha bisogno per liberarsi dell’exmoglie,
sa benissimo di andarsi a imprigionare in una residenza ancor più
spiacevole di quella da cui è appena fuggita. Ancora. Come abbiamo
detto prima, Marion, che s’è addormentata in auto, viene
sospettosamente interrogata da un poliziotto motociclista. Cambia
macchina, eppure ha visto che il poliziotto la segue. Perché dunque
sciupa settecento dollari nell’auto nuova?
Crediamo che i lettori non ci accuseranno di eccessiva sottigliezza
se sosteniamo che in questo momento, mentre è inseguita, Marion non
è meno alienata del padrone del motel che è destinata a incontrare
di lì a non molto. Si tratta, dunque, di un incontro fatale, perché
la giovane donna ha sbagliato addirittura strada. Ostinata nel
fuggire con i milioni, Marion si pente soltanto dopo l’incontro con
l’uomo del motel. Il poveretto le mostra gli animali impagliati, le
parla della madre inferma, del suo albergo senza clienti perché la
nuova autostrada ha deviato il traffico. Egli è solo come non si
potrebbe essere più soli. La malattia dell’assassino è la salvezza
spirituale di Marion. Essa comprende che, pur vicina all’uomo amato,
essa non sarà felice. Conviene restituire i quattrini e attendere
qualche anno sino a che i debiti di «lui» saranno stati pagati con
onestà. Perciò, con i mezzi del grandguignol, Hitchcock non ha fatto
che descrivere un dramma antico, il dramma della solitudine.
Guido Fink, Cinema Novo, 1960
|


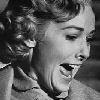
![]() Ultimo
aggiornamento:
23/04/2011
- Per suggerimenti e contributi:
E-mail
Ultimo
aggiornamento:
23/04/2011
- Per suggerimenti e contributi:
E-mail